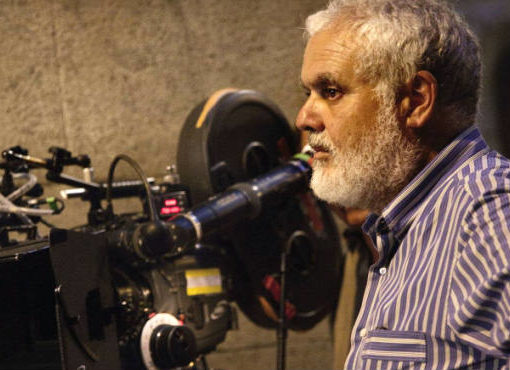Andrée Ruth Shammah dopo 35 anni riporta in scena a Milano l’intenso racconto dello scrittore di Novate ispirato a Manzoni Convincenti protagonisti Luca Lazzareschi e Laura Marinoni
Testori all’ennesima potenza. Giovanni Testori vivo nella sua parola incarnata. Necessario, oggi più he mai, per indicare una strada. Quella della redenzione che non è negata nemmeno a chi ha toccato il punto più basso del suo essere. Condizione marginale e periferica, condizione dell’escluso che, comunque, non smette mai – ecco il credo dello scrittore di Novate – di essere uomo. E che come tale va visto. Va amato. Parola che ti entra come unghie nella pelle quella di Testori. Ed è (paradossalmente) un piacere che non vorresti finisse mai. Non bastano (o forse sì, perché sono perfettamente compiute) le tre ore e mezza dei suoi I promessi sposi alla prova in scena con la regia di Andrée Ruth Shammah (la stessa del 1984) al Teatro Franco Parenti di Milano. La casa di Testori: su quelle assi di legno (quando il luogo di confronto civile attraverso il teatro si chiamava ancora Salone Pier Lombardo) ha preso forma e corpo la Trilogia degli scarrozzanti. Lì, nel 1984, Franco Parenti ha “detto” e fatto “dire” (agli attori di una compagnia chiamata a mettere in scena il più grande romanzo italiano) la parola del Manzoni. Testoriano ante litteram, verrebbe da dire ascoltando la densità della parola manzoniana restituita da Testori (manzoniano sin nel midollo, mettiamola così, viste le coordinate temporali) in tutta la sua umanità. Ancora di più, se possibile.
Perché la grandezza dello scrittore di Novate è proprio quella di incarnare (il termine per eccellenza del dio cristiano che si fa uomo) concetti alti nel quotidiano – in un pezzo di carne di manzo appoggiato sulla finestra a frollare, in un centauro che ha un incidente in moto e si spappola il cervello, in un bacio rubato e in un amore consumato in fretta sotto il ponte della Ghisolfa, in un tossicodipendente che muore di overdose nei bagni della Centrale dopo un delirio nel quale gli appare Cristo. Di farli diventare carne e sangue, pane spezzato del quale nutrirsi.
«Se qui sulla scena come nella vita doveste incontrare delusioni, amarezze, dolori è naturale. Capita, non abbiatene timore né vergona: bussate alla sua porta, ma bussate con forza, con fiducia e lei vi aprirà. Lei chi? La speranza!». Ecco la strada che il Maestro, il capocomico indica al termine de I promessi sposi alla prova. Parola che ti resta appiccicata addosso. Più forte della provvidenza evocata dal Manzoni. Perché implica una tensione, un movimento, suggerisce un’azione, evoca un fare piuttosto che un accettare. Ecco allora che l’attore che fa Renzo, l’attrice che fa Lucia, l’attrice che fa Gertrude, l’attrice che fa Agnese (così li indica in locandina il drammaturgo) non recitano battute di un copione, non evocano un racconto in terza persona, ma lo dicono, lo vivono. Si raccontano in prima persona, entrano nel testo del romanzo, lo frantumano, lo assimilano e lo restituiscono in un eterno presente che cattura il qui ed ora di personaggi vissuti (?) anni fa. Che è poi la forza della fede. Che Testori fa diventare vita nella sua riflessione sui Promessi sposi. Che a prima vista potrebbe sembrare pirandelliana nella sua costruzione di teatro nel teatro, di epifania improvvisa di personaggi (che un autore ce l’hanno, non lo cercano) che devono raccontare la loro storia. Che qualcuno ha già raccontato, ma che deve diventare vita.
C’è la forza, l’urgenza etica della tragedia greca nel testo dello scrittore. C’è la catarsi, con gli attori che nel diventare personaggi ritrovano la loro essenza di uomini: si chiedono il senso della vita, il perché del dolore, il significato da dare all’amore (Testori toglie a Lucia quell’aura da santa che spesso le letture scolastiche tendono a dare) quello carnale prima di quello spirituale. Lo chiedono a noi che stiamo in platea. Con la forza dell’urlo di Gertrude, chiusa nella “polera”, la stessa dove lei e l’Egidio – ma si chiamava Giampaolo, dicono i documenti storici: chiamiamolo allora il Giampegidio, suggerisce l’attore che fa Renzo –, dove lei e il Giampegidio hanno buttato la Caterina, la conversa uccisa perché aveva visto troppo. Dai sotterranei del palco, la “polera” appunto, Gertude appare e grida la sua rabbia. La butta in faccia al pubblico con la forza iconoclasta del primo Testori, quello di Tentazione in convento o di Passio Laetitiae et Felicitatis, quello che impasta carne e sangue nella parola che colora di dialetto brianzolo. E con le vette spirituali vertiginose raggiunte dall’autore dopo la conversione – anche se forse in Testori non ha senso un prima e un dopo, perché da sempre ogni parola è intrisa di umanità, che è poi l’espressione più alta di una fede che mette al centro un dio che si fa uomo.
Tutto questo rivive in scena. Nell’allestimento de I promessi sposi alla prova che Andrée Ruth Shammah riporta in scena a trentacinque anni dalla prima dalla prima edizione. Perfetto. Che ti cattura dal primo istante e non ti molla più sino alla fine. Grazie ala forza della semplicità: un palcoscenico vuoto (le scene sono di Gian Maurizio Fercioni, i costumi riportano indietro agli anni Ottanta), le pareti bianche, scale e cavalletti, fari e un sipario rosso calato, un tavolino ed alcune sedie. Bastano poche cose perché si prova uno spettacolo: la suggestione di un cielo stellato fatto di tulle, di un sipario che si alza, di sedie di paglia impilate. È la parola che evoca. Quella del Maestro di un intenso Luca Lazzareschi (che in un poetico omaggio lascia dire l’incipit del romanzo alla voce registrata di Franco Parenti, il Maestro nell’edizione del 1984, quando Testori lo guardava specchiandosi nel capocomico che condivide con i suoi attori ciò che a lui dice il romanzo) che restituisce la poesia di alcuni passaggi testoriani, quello sulla città su tutti. La parola di Laura Marinoni, l’attrice che fa (splendidamente) Gertrude, ma anche la Madre di Cecilia: «Sono qui sulla soglia di uno di quegli usci… Porto in collo una bambina… la mia, nove anni e già morta. Non a giacere la tengo, ma a giacere su di un braccio…» dice nell’eterno presente manzoniano. Madre, memoria di tutte le madri. Monumento e memento. E poi Filippo Lai e Nina Pons, gli attori che fanno Renzo e Lucia, Sebastiano Spada l’attore che fa don Rodrigo, Carlina Torta e Laura Pasetti, le attrici che fanno Agnese e Perpetua. Recitano (non sembra che lo facciano, però: sono) senza dizione, Testori li voleva così. Veri, autentici. Nudi nel loro essere uomini, quando alla fine si presentano con i loro nomi. Memoria dei personaggi per noi spettatori di oggi. Chiamati, potenza del teatro, ad interrogarci sul nostro (eterno) presente.